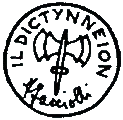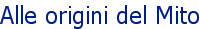- L'enigmatica Sfinge di Tebe infine si palesa
Pubblicato da Fernanda Facciolli in 1 Volti della Luna · 20 Giugno 2017
 Visitando la pianura del fiume Tenero che si stende ai piedi della collina di Tebe, a ovest dell’“isola”, Pausania si imbatte nel monte che si eleva a nord della piana e scrive:“…giungiamo al monte dal quale si dice che la Sfinge si lanciasse a rapire la gente e a ucciderla, ripetendo il suo indovinello. Alcuni però sostengono che essa, vagando da pirata con una flotta potente, si fermò nel mare di Antedone e, occupato questo monte, ne fece la base per le sue rapine, finché Edipo la uccise dopo averla sopraffatta grazie al numeroso esercito con cui era venuto da Corinto.” (l.IX, c.26, p.2).
Visitando la pianura del fiume Tenero che si stende ai piedi della collina di Tebe, a ovest dell’“isola”, Pausania si imbatte nel monte che si eleva a nord della piana e scrive:“…giungiamo al monte dal quale si dice che la Sfinge si lanciasse a rapire la gente e a ucciderla, ripetendo il suo indovinello. Alcuni però sostengono che essa, vagando da pirata con una flotta potente, si fermò nel mare di Antedone e, occupato questo monte, ne fece la base per le sue rapine, finché Edipo la uccise dopo averla sopraffatta grazie al numeroso esercito con cui era venuto da Corinto.” (l.IX, c.26, p.2).Rizzo, nelle sue note a Pausania, spiega: “E’ il monte della Sfinge (m.565) dalle cui falde iniziava il lago Copaide. I Beoti lo chiamavano Ficio o Ficeo da Phix, beotico per Sphix, v. Esiodo,Teog. 326…”. “Il noto indovinello (Quale è l’animale che cammina su quattro piedi, su due e su tre. Risposta: l’uomo) è riferito in formulazioni diverse da Aten. 10, 465b; scol.Eur. Fen.50; scol. Licofr. 7;A.P. 14, 64; Apollod. Cit.”. “Secondo il mito la Sfinge, figlia di Echidna e di Tifone, era un “mostro montano” (Eur. Fen. 806)… “crudivoro”, con volto di donna, petto, zampe e coda di leone, ali d’aquila e artigli di grifo. L’interpretazione razionalistica… faceva della Sfinge una figlia bastarda di Laio (o di Ucalegonte e moglie di Macareo…o moglie di Cadmo abbandonata…che, presa dimora sul monte Ficio, assaliva e depredava (e uccideva) tutti coloro che passavano da quelle parti, cogliendoli in una imboscata. Le forme ferine le vennero attribuite perché era feroce come un leone, predatrice come un uccello rapace e perché superava in velocità tutti i predoni suoi compagni (Cadmei al suo seguito, secondo Palefato). Edipo (o un suo omonimo…), venuto con altri compagni a far parte della sua banda, …, la uccise e ne portò il cadavere su di un asino a Tebe.” (pag.397).
Trovo nel dizionario di F. Montanari che il beota Esiodo, nella sua Teogonia, chiama la Sfinge Phix (leggi “fics”), genitivo Fikòs. Poi, trovo che figòs, gen. figou significa “quercia” e che figoon voleva dire “querceto”, mentre Fighion era il nome del Fegio, un monte della Troade.
Ne deduco che il monte della Sfinge (Sphgigx Sphiggos, h), lo Sfinghion, il monte beota di Tebe, era il monte “del querceto”, ricoperto di splendide querce, alberi simbolo della forza che viene donata dal cielo grazie alle acque.
Doveva essere ancora più bello e suggestivo del bosco sacro di Alalcomene e, poiché la sua propaggine occidentale sfiora le pendici orientali del massiccio del Vounio-Elicona-Parnaso, lo stretto passaggio tra la pianura di Tebe e quella di Orcomeno doveva essere facilmente controllabile da parte dei Tebani per sventare possibili invasioni da Ovest.
Oggi, sul monte Sfinge, sopra un valico percorso da una strada asfaltata che conduce ad Acrefnio, forse quella attraversata da Pausania, esiste ancora un monastero cristiano ortodosso dedicato a S.Giovanni Evangelista, in un punto ricco di sorgenti, indizio della probabile antica presenza di un santuario preistorico, forse dedicato alla Signora del Querceto o della Montagna. E’ possibile che da questo santuario scendesse veloce una guarnigione di Tebani ogni qual volta qualche straniero penetrava nella valle provenendo da Ovest o da Nord (Acrefnio). E’ anche possibile che le domande dei guardiani tebani agli stranieri (Chi siete? Dove andate? Cosa volete?) suonassero a quest’ultimi incomprensibili, come un indovinello. E che, alla mancata risposta degli stranieri, la guarnigione tebana, interpretandola come un rifiuto a rispondere da parte di spie o invasori, li scacciasse con la forza o addirittura li uccidesse. E’ anche possibile che ad un certo punto il presidio tebano sul monte Sfinge chiedesse ai pastori stranieri che transitavano di là un pagamento in natura per il“pedaggio” (come fecero i troiani sull’Ellesponto e i Romani sul guado del Tevere), guadagnandosi così la fama di pirati e predoni.
Interessante poi il particolare del mito classico in cui si dice che la Sfinge era a capo di una banda di briganti Cadmei e che Edipo era andato a far parte della sua banda; ma poi la uccise e la portò a Tebe a dorso d’asino. Che il re di Tebe a capo dell’armata tebana fosse un brigante di professione era sicuramente una invenzione calunniosa delle sue vittime. Forse all’inizio dell’età storica era ancora leggibile sul muro del santuario una pittura preistorica con la scena della Sfinge in groppa ad un asino e con un uomo, Edipo, che conduceva l’animale, interpretata come morte della predona. Ma il vero significato doveva essere invece il trionfo della dea Sfinge, che fa il suo ingresso trionfale in Tebe su di una Asina sacra, forse la dea Onca, con l’aiuto e il beneplacito del re di Tebe Edipo, mentre entra nella città attraverso la sua porta principale, la porta Elettra (o di Elettrione).
Ma resta ancora una domanda: perché la dea del cielo e della fertilità che aveva il suo santuario sul monte delle querce era stata rappresentata come un animale ibrido metà leonessa, metà donna, metà aquila? Si è risposto: “perché la leonessa è simbolo di forza, la donna simbolo di intelligenza simile a quella umana e l’aquila è l’emblema delle supreme altezze del cielo”.
Giusto, ma c’è dell’altro.
 Un giorno eravamo nella zona degli scavi archeologici del Cabirion, il santuario dei Cabiri citato da Pausania e posizionato sulle pendici delle alture che orlano da Sud la piana del Tenero e fronteggiano il monte della Sfinge. E allora la abbiamo vista. Abbiamo visto una scultura enorme, una montagna modellata dalla natura in forma di leonessa alata che sta per sorgere dalla pianura allargando le possenti ali. La testa guardava in là, verso il mare di Antedone, a Nordest di Tebe, un poco girata verso la sua ala destra per farci vedere bene il suo muso di madre leonessa che protegge i suoi cuccioli; le ali per metà uscite dalla piana, come se stesse emergendo da un pantano, il corpo ancora completamente sommerso. Uno spettacolo grandioso che ispirava reverenza. Era non sulla montagna della Sfinge, ma era la montagna stessa.
Un giorno eravamo nella zona degli scavi archeologici del Cabirion, il santuario dei Cabiri citato da Pausania e posizionato sulle pendici delle alture che orlano da Sud la piana del Tenero e fronteggiano il monte della Sfinge. E allora la abbiamo vista. Abbiamo visto una scultura enorme, una montagna modellata dalla natura in forma di leonessa alata che sta per sorgere dalla pianura allargando le possenti ali. La testa guardava in là, verso il mare di Antedone, a Nordest di Tebe, un poco girata verso la sua ala destra per farci vedere bene il suo muso di madre leonessa che protegge i suoi cuccioli; le ali per metà uscite dalla piana, come se stesse emergendo da un pantano, il corpo ancora completamente sommerso. Uno spettacolo grandioso che ispirava reverenza. Era non sulla montagna della Sfinge, ma era la montagna stessa.Ma c’è anche un altro luogo sacro da cui si riesce a vedere la sacra montagna per intero: davanti alla chiesa dei santi Costantino ed Elena (figlio e madre) ad Ambelochori, a monte del Cabirion, poco a Nord di Tachi. E’ possibile che il famoso bosco sacro di Demetra e Core visto da Pausania a Potnie si trovasse proprio qui, anche perché il nome Ambelochori può essere una corruzione di Amficore, cioè la doppia Core o le Due Signore.
Allora abbiamo capito che tutto aveva avuto origine nei tempi lontanissimi in cui gli uomini adoravano le montagne e non i simboli. La montagna coperta di querce era un animale vivente al pari della luna e del sole. Ma perché poi era stata dipinta con una testa di donna? L’unica testa che vedevamo era di leonessa. Dovevamo aspettare il giorno dopo.
Nella mattinata seguente ci siamo diretti con l’automobile verso la pianura Copaide, ad ovest di Tebe, e abbiamo imboccato la statale Tebe-Livadià che passa ora al centro di quella che nell’antichità era una zona acquitrinosa e forse malsana.  Avvicinandoci al monte Sfinge, abbiamo visto la Signora da vicino e spostandoci da Est a Ovest dapprima abbiamo visto solo la sua ala destra, poi abbiamo cominciato a scorgere il muso puntato a Nordest, poi abbiamo sorpassato la sua “colonna vertebrale” e ci siamo girati all’indietro per salutarla, ma…a quel punto abbiamo visto il…”volto umano” della Sfinge. Nel massiccio che costituisce la sua testa il muso ferino non si vedeva più ma lei ci presentava un viso di donna di profilo e supino, che guardava verso l’alto. Era come se la Signora, per seguire i nostri spostamenti, avesse girato la testa verso la sua ala sinistra e ci guardasse in tralice. Questa volta rivelandoci la sua vera essenza, di dea della terra.
Avvicinandoci al monte Sfinge, abbiamo visto la Signora da vicino e spostandoci da Est a Ovest dapprima abbiamo visto solo la sua ala destra, poi abbiamo cominciato a scorgere il muso puntato a Nordest, poi abbiamo sorpassato la sua “colonna vertebrale” e ci siamo girati all’indietro per salutarla, ma…a quel punto abbiamo visto il…”volto umano” della Sfinge. Nel massiccio che costituisce la sua testa il muso ferino non si vedeva più ma lei ci presentava un viso di donna di profilo e supino, che guardava verso l’alto. Era come se la Signora, per seguire i nostri spostamenti, avesse girato la testa verso la sua ala sinistra e ci guardasse in tralice. Questa volta rivelandoci la sua vera essenza, di dea della terra.
 Avvicinandoci al monte Sfinge, abbiamo visto la Signora da vicino e spostandoci da Est a Ovest dapprima abbiamo visto solo la sua ala destra, poi abbiamo cominciato a scorgere il muso puntato a Nordest, poi abbiamo sorpassato la sua “colonna vertebrale” e ci siamo girati all’indietro per salutarla, ma…a quel punto abbiamo visto il…”volto umano” della Sfinge. Nel massiccio che costituisce la sua testa il muso ferino non si vedeva più ma lei ci presentava un viso di donna di profilo e supino, che guardava verso l’alto. Era come se la Signora, per seguire i nostri spostamenti, avesse girato la testa verso la sua ala sinistra e ci guardasse in tralice. Questa volta rivelandoci la sua vera essenza, di dea della terra.
Avvicinandoci al monte Sfinge, abbiamo visto la Signora da vicino e spostandoci da Est a Ovest dapprima abbiamo visto solo la sua ala destra, poi abbiamo cominciato a scorgere il muso puntato a Nordest, poi abbiamo sorpassato la sua “colonna vertebrale” e ci siamo girati all’indietro per salutarla, ma…a quel punto abbiamo visto il…”volto umano” della Sfinge. Nel massiccio che costituisce la sua testa il muso ferino non si vedeva più ma lei ci presentava un viso di donna di profilo e supino, che guardava verso l’alto. Era come se la Signora, per seguire i nostri spostamenti, avesse girato la testa verso la sua ala sinistra e ci guardasse in tralice. Questa volta rivelandoci la sua vera essenza, di dea della terra.Pausania non ne parla, della montagna in forma di sfinge, e questo sicuramente perché lui seguiva la strada sottocosta, a causa della pericolosità di quella nella palude, e da quel punto di vista non si vede né la testa umana né quella di leonessa. Del resto, nessuno gliene aveva parlato, probabilmente perché il culto della montagna sacra si era perduto da più di un millennio ed era stata tramandata solo la storia della sua demonizzazione. Il ricordo, cioè, che era esistita una dea dal corpo mostruoso che difendeva i confini di Tebe, ma il cui culto non esisteva più perché essa era malvagia e comunque nemica degli stranieri.
Ancora un particolare: la Sfinge era stata moglie di Cadmo, segno che lei era stata la regina di Tebe e la sua divina Protettrice. E se Onca e Cadmo erano fenicio-egiziani, anche lei un po’ lo era.
Nel mio dipinto, ho umanizzato anch’io la montagna, ma non ne ho riprodotto l’aspetto reale (doppia testa umano-leonina e ali d’aquila), né l’ho rappresentata con l’icona classica che tutti conosciamo (testa umana, corpo di leone, ali di rapace), perché l’ho voluta effigiare all’egiziana (la dea egizia Sekmet aveva corpo di donna e testa di leonessa) e con ali d’uccello, come una dea delle altezze che guarda dal cielo la sua città prediletta e la protegge. Ho alluso all’abitato preistorico di Tebe con il cerchio crociato, in basso a destra, perché questo era il geroglifico egizio per “città”. E d’altronde, questa era davvero la forma delle
più antiche città del mondo: un cerchio di mura e due strade principali che si incrociavano al centro.
Non sono presenti ancora recensioni.